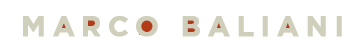Lo spettacolo ha un andamento per quadri. Come un attraversamento di gironi che all’infernale hanno sostituito la miseria dell’umano, e la sua grandezza rovinosa.
Come nelle “Sette opere di misericordia” del Caravaggio, nella chiesa del Pio Monte della Misericordia di Napoli, più eventi accadono contemporaneamente, più esistenze si frammischiano, in una visione più medievale che rinascimentale, in una coesistenza e sovrapposizione che non delinea un mondo ordinato dallo sguardo ma una realtà caotica e soverchiante.
La donna lo accoglie da vincitore, gli asciuga la fronte, gli trucca il corpo con un rossetto, lo veste da soldato americano, qualcuno suona uno straziante mandolino, l’uomo corre verso il muro e inarca il corpo in una parodia di atto copulativo, altri corpi via via partecipano al subitaneo coito, il percorso si ripete più volte, ogni volta la scena si fa più complessa, aggregando nuovi corpi agli appuntamenti (note dal diario di lavoro)
Immagino un procedere senza soluzioni di continuità, con improvvisi stacchi luminosi, squarci di luce in cui ci si concentra su quel paesaggio, si amplifica quella esperienza, si ascolta intensamente quella parola per poi assistere ad un mutamento, al trascorrere verso una nuova esposizione, che era già vivente nella prima, nascente da quelle stesse costole.
Un movimento delle braccia che è chiaramente riconoscibile come cullare un bambino, in crescendo, come per farlo smettere di piangere, le bocche si aprono, il respiro si fa affannoso, come quello dei cani, con le lingue di fuori.
Non ci sono quinte né nascondimenti. Tutto ciò che accade vive nello stesso spazio tempo, è parte di un unico grande e imprendibile affresco. Lo spettatore deve avvertire l’impossibilità di dare ordine, di avere una storia che ordini il tempo e lo spieghi.
Le scene e il loro susseguirsi sono il risultato di una perdita, la perdita della pelle, dell’involucro, della possibilità stessa di dare forma. Ciò richiede da parte degli attori una totale immersione nel presente degli accadimenti, una umanità con uno sguardo attonito, ripiegato su stessa, incapace di volare oltre quei corpi, al di là di quelle sostanze.
Ora è un vento forte che la scuote, torna ad essere falena con un agitarsi convulso e ritmato di braccia e gambe contro la parete, una mano è sempre verso l’alto e sbatte ossessivamente contro il muro. Lentamente la donna-bandiera si stacca dal muro e cade tra le braccia degli altri.
I corpi sono il segno-soglia da cui partire ogni volta e a cui tornare, come impedimenti necessari, portatori di bisogni, i più elementari, quelli crudi del vivere biologico, corpi fusi sempre in una più ampia coralità, di testo, gesti, danza. Ma anche corpi capaci di staccarsi e presentarsi come individui, divenire voci, messaggeri di parole.
Non è uno spettacolo su Napoli nel dopoguerra. La nottata non passerà più, non è mai passata. È uno spettacolo sul nostro mondo, sul nostro oggi. Lo spazio scenico è una stiva vuota, un deposito di scarti, umani e non, oggetti strappati al loro uso abituale e ricombinati come dopo un naufragio.
Per il resto la scenografia la fanno i corpi, il coro, le luci, che sono lampi caravaggeschi, che fanno emergere la corporeità dei quadri, per poi annullarli in bui improvvisi, in piccole luminarie, in lampade ad acetilene, in luci da sopravvissuti, incerte, traballanti, incomode, come se anche l’energia luminosa fosse malata e stanca, prossima a mancare. Dieci attori che costruiscono assieme un romanico affresco, impastando la materia, performativamente, per approssimazioni creative progressive.
Voglio dedicare questo spettacolo ad Antonio Neiwiller, che ho conosciuto tardi, ma che ho potuto vedere all’opera, quando dirigeva altri attori.
Quel suo modo do creare, senza aspettative, fiducioso nella creatività potenziale presente in ciascuno, quell’andare apparentemente senza meta, ma ogni giorno costruendo manufatti, intenzioni, frammenti, fino a ricomporre, sotto il segno della caducità e del tempo, uno squarcio di poesia vivente.
Marco Baliani