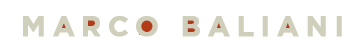CARISSIMA ADALGISA di Cristina Crippa
Negli anni ‘70, a partire dall’esperienza goriziana di Franco Basaglia, ha inizio un processo che investe, con modalità ovviamente differenti, molte città italiane: è l’“apertura” degli ospedali psichiatrici, opera gigantesca, processo lento e faticoso, percorso fitto di ostacoli e di muri, muri di pietre e di inferriate ma anche muri di burocrazia, di leggi, di complessi rapporti con la società esterna, ma soprattutto muri di paure e di pregiudizi alle prese con menti apparentemente, e talvolta realmente, irrecuperabili a un minimo di comunicazione interpersonale, a una possibilità di riappropriazione di sé stessi.
Eppure, là dove questo processo ha potuto almeno provare a cominciare, si è trattato di qualcosa di enorme, un cambiamento vero, una differenza abissale scavata granello per granello, per i “matti” e per gli operatori, che ha lasciato tracce profonde nella vita di tutti (e perdonatemi se parlo troppo e al contempo troppo poco e malamente di cose come queste, per molti certo ovvie e ben note; ma mi son fatta negli ultimi tempi la convinzione che non ci sia quasi niente che può essere dato per scontato – e così mi son fatta pedante e proseguo). Ad Arezzo c’era Agostino Pirella. E nel reparto infermeria, il cosiddetto “fondaccio” abitato dalle croniche agitate, situato (significatività della topografia) proprio accanto alla camera mortuaria, c’era una vecchia quasi sorda, ormai scarsamente in grado di recepire quanto le accadeva intorno, se non, certo, in termini di maggior benessere e dignità, col “sorriso incredulo” e la sigaretta tra le labbra. Adalgisa Conti. Nel ‘78, 91 anni, da 64 in manicomio. E la sua storia avrebbe potuto essere anche per noi una delle tante storie di donne “impazzite” e rinchiuse, storie che giornali, romanzi, cartelle cliniche, inchieste e la nostra stessa quotidiana esperienza ci hanno consegnato, vite tanto simili alle nostre che svoltano nell’afasia, nella distruzione, nella violenza, nel delirio. Un piccolo scarto, un incidente, una difficoltà troppo onerosa, miseria, mancanza di armi, uno squilibrio o un esproprio violento nella propria identità sessuale, la fatica e la solitudine della gravidanza e della maternità, il tuo corpo che non ti appartiene più, ed ecco menti e cuori si spezzano, si smarriscono in un labirinto, in un sogno nero da cui non è possibile svegliarsi.
Invece un evento forte e imprevisto muta la nostra possibilità di rapporto con la vicenda di Adalgisa. Luciano Della Mea, allora ricercatore per il CNR presso l’ospedale di Arezzo, lavora al riesame delle cartelle cliniche: da quella della Conti emergono alcune lettere, alla madre, al suocero, al marito, al medico curante: a quest’ultimo è indirizzata una lucida, sorprendente autobiografia: “Gentilissimo signor Dottore, questa è la mia vita”. Ecco, esiste questo racconto, estrema richiesta di ascolto e nel contempo tentativo di riafferrare un filo, c’è soprattutto il linguaggio di questa lettera, vivo, estroso, buffo nel suo tentativo di ripulirsi, di farsi convincente, quasi seduttivo.
C’è il riaffiorare prepotente dell’infanzia dei brevi giochi dei brevi sogni di una bambina e di una ragazza che scopre il proprio corpo, bello vivo sensibile, presto colpevolizzato e rinnegato. C’è l’infrangersi dei sogni in un matrimonio senza gioia, c’è il capriccio, la malinconia.
Anche il linguaggio si frantuma, si perde, mentre Adalgisa cerca di narrare i suoi ultimi giorni prima del ricovero: un tentativo di suicidio fiorito e visionario. Dopo questa lettera senza riscontro, Adalgisa tace, diventa – realmente – una paziente del reparto agitate, “sudicia, erotica, impulsiva, clamorosa”. E, per quasi settant’anni, “invariata”.
Con non poche traversie e dubbi finalmente nel ‘78 l’autobiografia di Adalgisa Conti diviene un libro, per l’editore Mazzotta, col titolo Manicomio 1914, curato e voluto da Della Mea e dal collettivo delle operatrici psichiatriche della Provincia di Arezzo, correlato da interviste, cartelle cliniche, resoconti di dibattiti fra medici e infermieri del reparto di terapia occupazionale donne a cui la Conti era stata assegnata dal ‘74 (chiuderà nel ‘75 il “fondaccio”).
Se a nulla era servito nel 1914, grande credo sia stato il potere di questo scritto al momento della sua scoperta. Ormai la vita della Conti non poteva più essere mutata, pure credo che la forza di quella narrazione abbia riverberato un po’ di luce sugli ultimi anni di questa donna, la cui memoria era ritornata a fissarsi in un eterno presente della sua giovinezza, in quei balli, in quella musica, nell’immagine di quel “giovanotto bello” divenutone poi il marito e il principale nemico e artefice della sua reclusione.
E una specie di vitalità disperata, un segno buono e augurale, sembra germogliare ogni volta che si ripete il gesto di aprire e leggere (la cartella clinica, il libro). A Milena Moriani, pittrice pisana (la cui biografia, lei stessa mi suggerisce, si può riassumere in “vive e lavora”) la vicenda ha ispirato tele bellissime.
A me che in una notte di incertezza durante le prove del Peer Gynt mi sono arrampicata a tirar fuori dalla libreria quel volume parecchio ingrigito, alla ricerca di un personaggio per una piccola improvvisazione, quella persona-personaggio ha preso la mano, si è allargata, si è presa spazio, si è conquistata respiro, voce, corpo e nuove orecchie di ascoltatori, mi ha consolato, per aver abbattuto un po’ bruscamente certe mie resistenze personali, dovute a vecchie storie dolenti un po’ rimosse ma non certo dimenticate, innescando per me una serie di incontri che sento come buoni e vitali.
Dello spettacolo, giunti ora alla vigilia dell’ultima tappa, molto non vorrei dire – sia perché presenta ancora ovviamente molti aspetti ignoti sia perché si presume che quando leggerete stiate per vederlo o l’abbiate già fatto. Solo vorrei segnalarvi che – forse per la natura di germoglio, di ovulo in moltiplicazione di questa storia – la prima cosa che è accaduta è stato un raddoppio, cioè siamo diventate due, io e Patricia. Abbiamo dato ad Adalgisa una infermiera guardiana sorella custode dei rituali e complice delle rappresentazioni e ri-presentazioni che qui si attuano, corpo rigido o trasformistico a un tempo, pronto a incarnare le visioni dell’altra; abbiamo esplorato il filo elastico che le unisce, la continua interdipendenza e reciprocità che le rende in definitiva una coppia.
Ancora qualcosa invece avrei bisogno di dire sulla scrittura di Adalgisa e su quello che mi sembra essere il nocciolo della sua storia.
“Io l’ho vista sai quella pianta, che si chiama agave, l’ho visto quel grandissimo fiore frutto a forma di albero che lei fa e poi muore” – così mi dice mio nipote, 6 anni, e l’altro, il cugino, mio figlio, che per un gioco fra compagni deve inventare una bugia, racconta “Ho incontrato due serpenti, di quelli che stritolano, due boa, e ci siamo baciati come due innamorati”. E mi ronzano nella testa queste cose mentre penso ad Adalgisa, a quella serpe che l’attrae e impaurisce sulla strada di San Leo (“ogni giorno divento sempre più rimbecillita, che pure scrivendo non so cosa dire, rimango incantata, come rimasi incantata da una serpe quando stavo a San Leo”), al quadro di Milena che si intitola Incantamento. E mi viene in mente la storia di Tiresia (come divenne donna, come tornò uomo, come parlò di un segreto che non andava svelato, come fu accecato ed ebbe il dono della veggenza).
E rivedo questa donna che scrive in una condizione incredibile, insieme di privilegio e di violenza (perché non era consentito possedere né carta né penna, avendo necessità di scrivere si veniva accompagnati da un’infermiera in direzione, e l’infermiera controllava per tutto il tempo), è “alfabeta”, certo, ma non si sente né poeta né scrittrice, vuole solo uscire, conosce un solo modo per rapportarsi a quel dio maschio che tutto può che è il dottore, un tentativo di seduzione, una sorta di complicità tra vittima e carnefice. Certo, la colpevolizzazione del proprio corpo e della propria sessualità è già molto interiorizzata, pure talvolta affiora una rabbia, le parole dicono l’esatto contrario di quello che appare, le sue dichiarazioni assumono la tragicità di un’abiura.
E Adalgisa parla, parla, e le sue parole, presa diretta, quasi prolungamento del corpo parlante, la trasportano forse più lontano del previsto, esplodono e illuminano una zona d’ombra e di interdizione. È del suo sesso di donna che Adalgisa dice, del suo corpo, della sua infanzia e adolescenza, del suo desiderio limpido e concreto, dei desideri possibili e di quelli che devono rimanere inaccessibili, della conoscenza e dell’esperienza di sé in assenza dell’altro, del bisogno profondo che nel rapporto con l’altro coesistano forze dall’apparente incompatibilità, concretezza estrema, pelle nervi e poi occhi parole discorso immaginazione, perché paradossalmente sono il desiderio, l’erotismo, il sesso, più ancora dell’amore e degli affetti, a nutrirsi di sogni, rituali, rappresentazioni.
Tutt’altro che l’essere in preda agli umori del proprio utero e del proprio apparato genitale appare la donna, a cui gli alienisti dell’800 erano fin pronti a riconoscere una parziale irresponsabilità giuridica (il che non voleva dire che cadesse la necessità della segregazione – anzi).
E l’uomo teme le donne, il loro mistero, quei loro organi strani e potenti di una forza oscura, come qualcosa di estremamente pericoloso a sè.
“Non so se a scrivere tutte quelle sudicionerie ho fatto bene o male”. Adalgisa, donna che sa con precisione cos’è un orgasmo, che dichiara di non provare nulla durante il rapporto sessuale col marito, che reclama un suo diritto al piacere, che, senza alcun disprezzo anzi con molta pietà, sente però di non voler condividere il destino delle donne “che passano la vita come schiave del marito” o “fatte vecchie, attempate, zitellone” perché “tradite, abbandonate” da un qualche uomo, ha su di sé il peso di una terribile aggravante: è una donna sterile, le sue richieste sessuali che non servono a gratificare l’uomo e non sono redente dalla sofferenza e dai sacrifici della maternità, sono pretesa assurda, capriccio, lussuria esecrabile. “Furba la puttana” e “Questa donna me la dovete cavà, con questa non ci posso vivere”. E Adalgisa, col suo “caratteraccio”, sbatte la testa contro i muri, i suoi tentativi di riaffermazione le si rivoltano contro, comincia a dubitare della propria innocenza e della propria normalità. E compie uno strano rituale, forse dei preparativi a un suicidio/sacrificio (suicidio che tenterà più volte effettivamente in ospedale) che con tutti quei fiori e lumini adombra forse la sua mancata festa nuziale.
Quanto all’autobiografia, mi viene ora il dubbio che proprio quella lettera, che a noi oggi fa dire “ma quella donna non era matta per nulla”, abbia in realtà sancito definitivamente la sua “scandalosità” sociale.
Ultima cosa: il titolo Lola che dilati la camicia è una canzone, ma una canzone storpiata (dilati sarebbe di latti, bianca: è il preludio della Cavalleria rusticana) citata in un racconto di Alda Merini, a cui molto volentieri la rubo, perché è un verso allegro, ma nella sua alterazione un po’ surreale ed esagerato e di colpo tragico. Con affetto per questo nostro lavoro che tende così caparbiamente alla metamorfosi e all’instabilità.
Cristina Crippa, maggio 1996