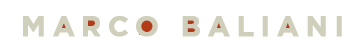“Mi colpisce, una volta di più, la constatazione che spesso ai giorni nostri verità vecchie come il mondo passano per parole d’ordine nuove fiammanti. O sarà sempre stato così?”. La costernazione del professore – protagonista del romanzo di Ödön von Horváth – davanti ai temi dei suoi allievi, mi accompagna mentre cerco di dare voce ai motivi che hanno determinato, oggi, la scelta di portare sulle scene Gioventù senza Dio. Che dire, al di là di quello che stiamo facendo nel quotidiano lavoro teatrale, mettendo a confronto le nostre scelte drammaturgiche con la sensibilità e l’immaginario dei giovani attori? Che dire di una scelta teatrale che trasferisce un romanzo ambientato nel periodo nazista alle scene dei nostri anni Novanta? All’inizio c’è il romanzo, appunto; e l’emozione suscitata dall’incontro con i suoi personaggi e le sue situazioni. Un’emozione resa inquieta e attiva dalla netta percezione che questa vicenda di un adulto come tanti, alle prese con l’impossibilità di agire il suo ruolo di educatore nei confronti dei giovani che gli sono affidati, ci riguardi molto da vicino. Un adulto come tanti: consapevole, ma fragile, sommerso dal rumore di un’epoca in cui gli slogan diventano modelli di comportamento; un adulto incapace, o nell’impossibilità, di usare il suo sapere o il suo lavoro per entrare in relazione con gli altri: i suoi giovani allievi, in particolare, ma anche i colleghi, i familiari, gli occasionali compagni di strada. Non ci sono azioni, strumenti efficaci per intervenire sulla realtà, quando la si vede come irreversibile, senza possibilità di trasformazione. Dall’altra parte i giovani, che la scuola e la propaganda vogliono tutti uguali, in una martellante omologazione che rende tutto facile, basta copiare… quei giovani che, per parafrasare le parole del cinico Giulio Cesare del romanzo, dopo aver subito il furto della loro adolescenza e avere visto i loro più intimi sentimenti “sfruttati da stregoni” , si ritrovano il “sarcasmo come ideale”, l’impassibilità come prospettiva. Capaci di tutto, una volta che la curiosità per il reale, nelle sue molteplici manifestazioni, ha soppiantato definitivamente la ricerca della verità. È l’evidenza di questo legame, in un banale e devastante atto privo di necessità e intenzione, a scardinare i precari equilibri dei compromessi quotidiani. Perentoria, come la chiamata di un Dio implacabile, questa evidenza esige una risposta: un atto di verità, se ancora non si può o non si sa nominare l’amore, può essere il gesto elementare da cui partire per ricominciare a costruire.
Su queste tracce si è sviluppata la struttura drammaturgica: dapprima una riduzione del romanzo, per fissare gli snodi del racconto scenico, poi progressivamente, i movimenti degli attori, i loro racconti, le loro immagini, attraverso le situazioni e le parole del romanzo. Il tutto accompagnato da battute e considerazioni “chiave”: non didascalie di un’impossibile dimostrazione, ma fuochi della nostra attenzione, un filo rosso che ci mantiene ancorati alle prime emozioni della lettura e alla trama delle nostre domande.
Ci è sembrato di doverci attenere al testo di Ödön von Horváth, come unico materiale verbale del racconto scenico, per evitare ogni facile tentazione verso l’attualità, magari quella della cronaca. Lasciando l’ambientazione originaria del romanzo, anche attraverso vicende e parole chiaramente datate, ci è parso che risultasse più forte il permanere di alcuni nuclei problematici e domande che i nostri tempi tornano a rendere prepotentemente visibili e impellenti nella loro richiesta di considerazione. La distanza fra l’epoca del romanzo e l’attualità dei corpi che gli danno vita dilata lo spessore dell’azione sulla quale cerchiamo di guidare lo sguardo dello spettatore. Semmai, se di “attualizzazione” si deve parlare, questa riguarda il teatro, la nostra scelta di usare la scena come strumento per confrontarci sui problemi che ci riguardano come spettatori, per esplorare dall’interno d una pratica consapevole e fragile, la nostra capacità di parlare delle cose che ci stanno a cuore.
È un possibile senso del teatro, in fondo, quello di cercare e di agire – nel limitato spazio di uno spettacolo – le conseguenze di una visione.
Renata Molinari